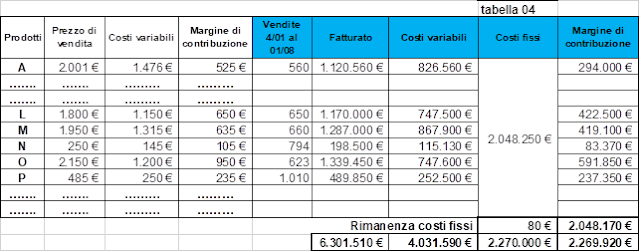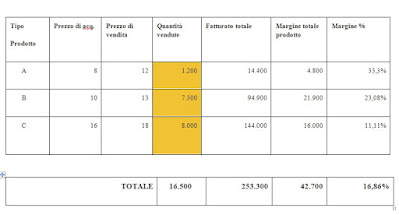a cura di Roberto Budassi - Medico Pediatra
Capitolo 4
Quando veniamo infettati per la prima volta da un virus o un batterio, il nostro organismo mette in atto una specifica risposta immunitaria di difesa, attivando una serie di cellule specializzate, alcune che producono anticorpi, detti anche immunoglobuline – Ig, (linfociti B), altre che sono in grado di distruggere le cellule infettate (linfociti T citotossici) e altre che sono in grado di riconoscere il germe in caso di una nuova infezione (linfociti T della memoria). Si assiste dapprima alla produzione di anticorpi della classe IgM, più grossolani e di efficacia ridotta, per arrivare nel volgere di un certo numero di giorni a quelli di classe IgG, molto più affini all’obiettivo, quindi più efficaci ed anche più duraturi. Il problema è che nel lasso di tempo che intercorre fra l’infezione e in momento in cui le difese diventano efficaci è possibile che si sviluppi una malattia che può risultare anche molto grave ed a volte fatale.
Ovviamente chi ha superato la malattia ha prodotto una certa quantità di anticorpi IgG che lo hanno guarito e che lo difenderanno per un certo periodo di tempo da una eventuale nuova infezione con lo stesso germe. È il discorso del plasma “convalescente” di cui abbiamo trattato in precedenza. Non solo, ma in caso di reinfezione verranno prodotti rapidamente ulteriori anticorpi IgG da parte di linfociti B a loro volta attivati dai linfociti T della memoria immunitaria, i quali anticorpi si sommeranno a quelli già presenti in circolo. È anche possibile che entrino in gioco i linfociti T citotossici arruolati nel corso della prima infezione. Questo complesso processo che si attiva nel momento di una eventuale reinfezione è detto risposta secondaria ed è solitamente in grado di impedire l’instaurarsi di una seconda malattia, quanto meno nelle forme più gravi.
L’azione dei vaccini è proprio questa: suscitare una robusta risposta secondaria senza prima dover passare attraverso i rischi della malattia naturale dovuta alla prima infezione. Per fare ciò un vaccino deve essere in primis immunogenico, cioè capace di attivare una risposta immunitaria, la qual cosa si può controllare attraverso il dosaggio degli anticorpi IgG, e poi per via degli anticorpi prodotti deve risultare anche protettivo, e questo lo possiamo verificare attraverso la sperimentazione sul campo, ne parleremo più avanti. In sostanza la risposta immunitaria indotta dal vaccino deve dare origine ad una buona quantità di anticorpi e che siano quelli giusti, cioè in grado di neutralizzare il germe incriminato, altrimenti sarebbe come una zecca che stampa soldi falsi. Infine, la citiamo per ultima ma è una qualità irrinunciabile che va considerata per prima, un vaccino deve dimostrare di un buon profilo di sicurezza, cioè non causare effetti indesiderati così importanti da sconsigliarne l’utilizzo.
Dobbiamo anche puntualizzare che un vaccino risulta protettivo anche se non induce la produzione di tutti gli anticorpi che si sviluppano durante la malattia naturale. Infatti per neutralizzare un qualsiasi germe patogeno è sufficiente disporre anche di pochi anticorpi, ma che siano in grado di interferire efficacemente su di una sua funzione fondamentale. Nel caso del SARS-Cov2, tutti i vaccini, indipendentemente da come siano stati costruiti, stimolano la produzione di anticorpi IgG diretti verso la proteina Spike del virus che, come abbiamo visto in precedenza, è fondamentale perché il virus possa entrare nelle cellule. Bloccando la funzione della proteina Spike, il virus non può entrare nella cellula e l’infezione non può avvenire. Abbiamo già visto che diversi anticorpi monoclonali hanno lo stesso meccanismo d’azione.
In realtà produrre un vaccino è una lunga e complessa operazione che dall’ideazione all’ingresso nella pratica clinica, passando attraverso varie fasi sperimentali, diverse autorizzazioni e poi processi industriali, necessita generalmente di molto tempo, in media di circa 10 anni.
Tuttavia i primi vaccini contro il Covid sono entrati nella pratica clinica dopo appena 10 mesi di sperimentazione, e ciò è stato realizzato senza scorciatoie e rispettando tutte le cautele necessarie, nello stesso standard di tutti i vaccini già in uso verso altre malattie. In altre parole la grave situazione pandemica ha reso necessaria la messa in campo di ogni azione in grado di abbreviare i tempi di ciascuna fase, ma senza nulla concedere alla fretta. Potremmo riassumere i cardini di questa operazione in cinque punti fondamentali:
1. Rapida divulgazione delle nuove conoscenze fra i ricercatori; inoltre immediata adesione alla ricerca da parte dei migliori centri universitari e i migliori ospedali nel mondo. Trovare il supporto scientifico di centri “di livello” costa molto tempo: almeno un anno risparmiato.
2. Utilizzo di tecnologie già note. Trattandosi di un coronavirus simile a SARS-Cov e MERS-Cov (di cui abbiamo già parlato nel capitolo 2) i metodi per produrre i vaccini erano già pronti. Fino a 5 anni risparmiati.
3. Finanziamenti immediati e sicuri da parte degli Stati, rischio finanziario zero a carico delle aziende, che non solo non hanno risparmiato sforzi nella ricerca, ma hanno anche prodotto considerevoli quantità di vaccini prima del termine della sperimentazione e della successiva approvazione (che poteva anche non arrivare) e hanno reso i primi lotti immediatamente disponibili. Fino a 3 anni risparmiati.
4. Sperimentazione ultra-rapida:
b. Stante la gravità della situazione, si sono resi disponibili immediatamente tutti i volontari necessari, tanto che il reclutamento è terminato in poche ore invece di molti mesi: un anno risparmiato.
c. Le fasi sperimentali di sicurezza e immunogenicità (fasi 1 e 2) sono state portate avanti assieme, circa 6 mesi risparmiati.
d. La fase sperimentale 3, in cui si saggia l’efficacia del vaccino sul campo, è stata brevissima. In questa fase un certo numero di volontari viene trattato con il farmaco in studio, nel nostro caso il vaccino contro il Covid, ed un numero simile viene trattato con un placebo, un finto vaccino, cioè una sostanza priva di qualsiasi azione farmacologica, senza che né il volontario e nemmeno lo sperimentatore conoscano a chi sia stato somministrato il farmaco e a chi il placebo (sperimentazione in “doppio cieco”). La sperimentazione di fase 3 cessa al raggiungimento di un certo numero di casi di malattia, la qual cosa in genere può richiedere anche anni. Nel nostro caso l’obiettivo è stato raggiunto in soli alcuni mesi, in quanto sono stati coinvolti molti più volontari del solito (decine di migliaia, invece di alcune migliaia), poi tracciati in zone ad alta densità di contagio (Brasile, India e USA, per esempio).
5. Generalmente l’enorme mole di dati prodotta nel lungo periodo di sperimentazione viene trasmessa in blocco agli organi regolatori (per es. FDA. negli USA, EMA per l’Europa e AIFA in Italia) solo al termine della sperimentazione stessa, i quali organi regolatori impiegano mediamente da uno a 3 anni per studiarli ed infine per autorizzare l’utilizzo clinico del farmaco o vaccino che sia. Questa fase è stata enormemente compressa, utilizzando la tecnica della cosiddetta “rolling review”, per cui i dati sono stati trasmessi agli organi regolatori alla fine di ciascuna fase sperimentale, rendendoli edotti sui risultati in tempo reale. Alla richiesta di autorizzazione l’esame dei pochi dati rimasti è stato rapido e immediato. Da uno a tre anni risparmiati.
Con questo capitolo abbiamo concluso la trattazione di alcuni aspetti fondamentali di questa nuova malattia, per certi versi straordinaria ed unica. Abbiamo trattato della incredibile possibilità di espansione del contagio, di quanto possa risultare grave il processo patologico, abbiamo accennato alle poche ma sempre più efficaci armi che abbiamo per curarla ed ai mezzi per prevenirla, cioè dei vaccini. Il prossimo e ultimo capitolo tratterà degli scenari futuri, in cui analizzeremo le variabili che influiscono su ciascuno degli aspetti precedentemente trattati.