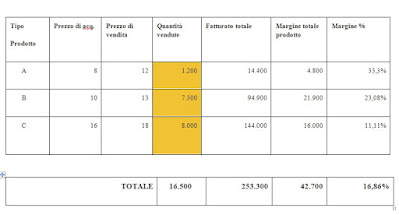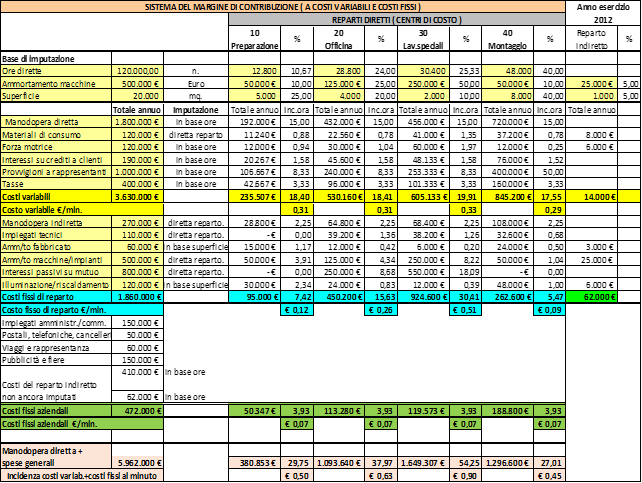di Giovanni Pelosi
(Foto di Patrizia Renzoni)
La consegna dei neonati al
conservatorio di San Michele, avveniva, come già detto, o attraverso la Ruota,
che verrà soppressa il primo luglio del 1873, o direttamente, specie se
provenivano dalle varie località fuori Fano, inviati da sindaci o parroci che
segnalavano o meno l’avvenuto battesimo. Nel primo caso era il suono di una
campanella che faceva accorrere subito la nutrice che disponeva di una camera
vicino alla Ruota.
A sua disposizione, tra gli
altri minuti oggetti, aveva un caldaro con catena, una graticola con treppiedi
per preparare il cibo, un mastello con tavola per lavare, un pannicello bianco
e uno rosa con una cuffia per il battesimo, una pila per l’acqua santa, otto
coperte piccole di diversi colori, un letto e due sedie di sgarza. Tutt’altro
che rari i casi in cui la balia si ritrovava tra le braccia neonati morti o in
condizioni pietose: “poco distante da Porta Giulia fu ritrovata una creatura
nata allora, involta in uno straccio, posta per terra e pioveva dirottamente”, “verso le dieci
pomeridiane si ritrovò un cestello fatto di vimini con un infante in pannolini
laceri, con una cuffietta in testa guarnita di un merletto ordinario, un panno
lacero di bavella per coperta, una lacera punta di fazzoletto rosa fiorato di
bianco e sotto la testa un piccolo cuscinetto riempito con foglie di formentone”.

A volte i neonati portavano
addosso tra i miseri stracci che li ricoprivano, vari segni di riconoscimento:
medaglie, fedi di battesimo, parti di monete, immagini sacre, un rosario.
Il tutto lasciava intendere l’intenzione di un futuro riconoscimento da parte
dei propri genitori. Non mancavano, comunque, episodi di volontà infanticida
dal momento che diversi venivano lasciati anche in luoghi non particolarmente
frequentati come i parapetti di muri e lungo la spiaggia.
Ad ogni esposto veniva
mantenuto il nome se riportato al momento della consegna, diversamente anche il
cognome si ricavava dal libro dei Santi, da quello dei Martiri (il “Martirologio”)
o dal mondo vegetale, animale o minerale; da qui i vari Orti, Civetti,
Cetrioli, Pratri, Volpi, Porfidi… Dopo un breve periodo di allattamento i
neonati venivano affidati a nutrici esterne che venivano scelte dopo una breve
visita per la loro giovane età, per qualità e quantità di latte. Ben volentieri
esse si prestavano a tale compito perché ricevevano non solo un buon numero di
pannolini di lino e canapa secondo le varie stagioni, il vestiario, i
medicinali in caso di malattia, ma anche un contributo bimestrale in denari e
diversi in natura.
Ai primi dell’800 vengono
registrate 81 balie; tutte risiedevano nelle campagne in prossimità di Fano, ma
non solo. IL numero più consistente si trovava nelle seguenti località:
Rosciano 12, Cartoceto 12, San Cesareo 11, Ferretto 11, San Costanzo 10,
Bellocchi 8, Mondavio 1, Novilara 1.
Gli esposti rimanevano
presso le loro balie fino al settimo anno di età, poi venivano dati in adozione
a loro stesse o ad altre famiglie ricevendo tutte un contributo in danaro. Le
femmine rimanevano fino al loro matrimonio, i maschi fino al 16^ anno; dopo non
erano più sotto la tutela del Conservatorio.
Differenti
destini
Piuttosto frequentemente, i
maschi adottati in campagna, vi rimanevano come garzoni, venivano addestrati
nei vari lavori colonici consentendo ai mezzadri di poter contare su una forza
lavoro che, anche se giovane, doveva adeguarsi alle loro condizioni di vita,.
Meno consistente era il numero di quelli che venivano adottati in città per
essere avviati ad imparare un mestiere quale il sarto, il falegname, il fabbro;
a volte però, considerato che non percepivano alcun compenso, andavano ad
ingrossare le file dei vagabondi imparando “le arti più infami in danno della
loro anima perdendosi nei maggiori vizi”.
Le esposte godevano, invece,
di una maggiore cura; quelle che non potevano essere collocate in campagna o in
città per problemi di salute, rimanevano al Conservatorio di San Michele, si
occupavano di servizi interni, venivano avviate alla lettura e alla scrittura e
due volte alla settimana si recavano presso l’orfanotrofio femminile a tale
scopo. Potevano comunque rimanere nel brefotrofio vita natural durante a meno
che non si scegliesse la via del monastero o quella del matrimonio che poi
costituiva la meta finale per il tipo di educazione ricevuta. Per le esposte,
il lavoro non costituiva necessariamente un passaggio obbligato per l’inserimento
sociale; se adottate in città diventavano serve e impiegate nei lavori più
umili e, se presso le famiglie contadine, oltre ai lavori in casa, venivano
mandate nei campi. Non doveva essere facile per queste fanciulle, abituarsi fin
dalla più tenera età a condurre tale vita, per cui diverse vi rinunceranno
ritornando al Conservatorio, altre passeranno da un padrone all’altro. Non
mancano casi di resistenza ad adattarsi a tale sorte: Balda, per la quarta
volta, verrà consegnata all’originaria famiglia di Mombaroccio e a lei verrà
richiesta “soggezione, obbedienza e l’obbligo di adempiere ai suoi doveri se
non voleva essere mortificata”; la stessa preferirà tornarsene nel brefotrofio
e lì vi morirà. Anche la condizione di
serva in città, non sempre le poneva in una posizione privilegiata; verranno
nel corso dei tempi segnalati vari casi di vero e proprio sfruttamento, diverse
non percepivano salario, non sempre erano fornite di vestiario adeguato o di
sufficiente cibo. Era, in verità, previsto un atto scritturale che impegnava le
famiglie che chiedevano le esposte, a servirsi della loro casa o dare un
sufficiente salario, fornirle di quanto poteva servire per i loro bisogni e
trattarle con il dovuto rispetto. Quando poi il conservatorio procedeva ad una
verifica, il quadro che si presentava non era sempre dei migliori; ecco alcuni
racconti: l’esposta Bartolomea “sono stata con il signor Lanci 9 mesi e credo
dover aver non so più quanto”; Francesca “sono stata con una donna Fenice
Brizia e quando me ne partii restò a dare quindici giorni e ne ho avuti dieci”;
Margarita “sono stata con il signor Flaminio Gisberti otto mesi e me comprò un
panigello di bambagia con doi para di scarpe e non ho avuto altro, con il
signor Averardo Lanci doi anni et ho avuto ora una cosa ora un’altra e non
credo essere soddisfatta”